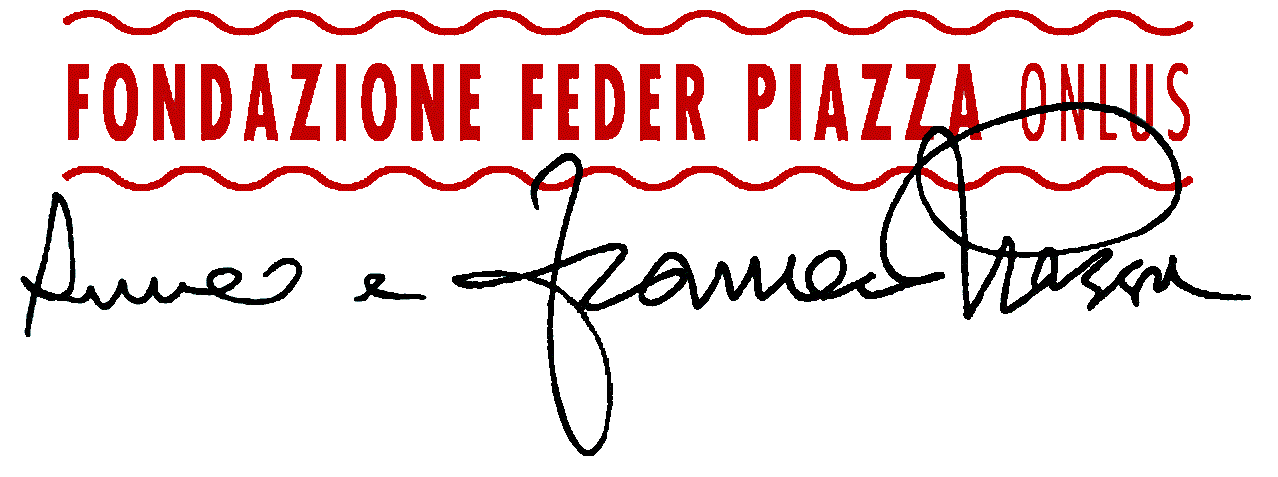|
IL LIBRO DELLA
GENESI RECITATO E ILLUSTRATO
|
|
MOSTRA A POSTIOMA
DI PAESE
invito
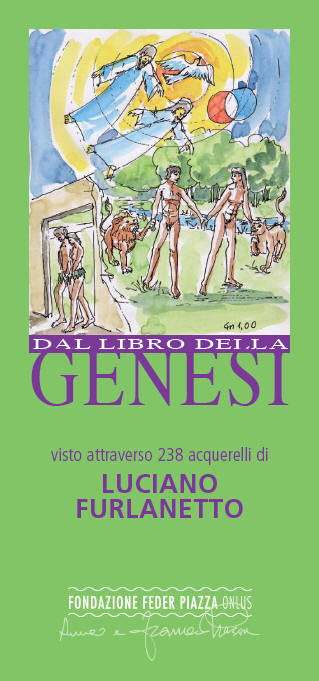
|
da La Vita del Popolo, domenica 2
novembre 2014
RIFLESSIONE. Rileggere
la "Genesi" con gli acquarelli di Luciano Furlanetto.
All'inizio della
nostra storia
Di lui hanno scritto
che la sua produzione artistica va ben oltre il tratto
grafico che la anima. Oltre l'ispirazione che l'ha generata,
come ubbidisse - è l'eterna meraviglia dell'arte - a
sollecitazioni che non conoscono la quotidianità e si
sottraggono al tempo.... Ci ha lasciato da poco Luciano
Furlanetto, ma ci manca. Ci manca tanto l'uomo con il suo
entusiasmo tutto scautistico, la sua fantasia fervida e
generosa, il professore che ha fatto dell'arte la ragione
profonda della sua esistenza sino a trasformarla in uno
strumento privilegiato per leggere la vita, per ascoltarne i
battiti e le movenze, in una via d'accesso alla conquista di
interiorità più profonda.
I soggetti religiosi
che hanno scandito la sua ricerca artistica - la "Via
Crucis" in terra cotta che si ammira nella chiesa del Sacro
Cuore a Treviso, gli affreschi che campeggiano nella Chiesa
Parrocchiale di S. Floriano ad Olmi di San Biagio di Callalta, il grande pannello in ceramica con "il Risorto, la
Vergine e San Floriano", ma anche le altre opere meno note
presenti in gallerie private e pubbliche - sono felici
corollari dei 238 acquarelli che illustrano il Libro della
Genesi e degli altri 280 che raccontano il Vangelo secondo
Matteo.
Sono momenti legati
da un unico filo conduttore che delinea un percorso che non
è soltanto artistico, ma personale, intimo, interiore,
nutrito di silenzio creativo e profonda meditazione. Sono
tessere di un puzzle che compongono una mappa mediata da un
continuo dialogare con la Parola che non muta, perché
composta da sillabe eterne che Luciano Furlanetto traduce in
immagini leggere ed essenziali, profondamente tenui e
delicate. Così la lettura che della Genesi dà Furlanetto,
riesce davvero a cogliere l'essenziale di una narrazione che
sta all'origine della nostra storia del mondo e al vissuto
di noi credenti, quasi a sollecitare, in chi ne osserva i
tratti, l'avvio di scoperta di segni nascosti, di
significati reconditi che l'immagine e il colore,
delicatamente, impongono e suggeriscono. Il genio e la
fantasia creativa di Furlanetto, il suo personalissimo ed
originale linguaggio artistico coinvolgono l'osservatore
sino a rapirlo e invitarlo a completare immagini talvolta
appena abbozzate, fragili nella loro consistenza
architettonica, delicate nel segno che le anima, anche
quando raccontano la drammaticità di scene angosciose.
L'occasione per
ammirare gli acquarelli che Luciano dedica alla Genesi ce la
offre la bella mostra pensata per la settecentesca chiesa di
Postioma di Paese che vedrà la sua inaugurazione il prossimo
8 novembre alle 20.30, per proseguire nelle ore pomeridiane
delle domeniche 9, 16, 23. Una rassegna che darà anche modo
di ammirare i tesori di questo gioiello artistico che
conserva le quattro grandi tele del veneziano Canal e regala
al visitatore tra gli altri tesori anche i quattro monocromi
ovali dedicati alle tre Virtù teologali e alla Pazienza. Una
degna cornice per far posto agli acquarelli di un artista
amato e compianto, del quale tutti hanno ammirato e
continuano ad ammirare l'immaginazione e l'abilità
narrativa, «la grafia stilizzata che permette una lettura
veloce delle scene», come ha sempre sotto-lineato la critica
artistica. (Mario Cutuli)
|
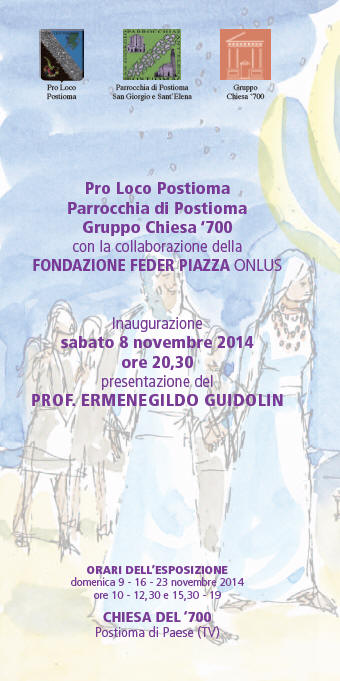 |

 
Omaggio floreale alla signora Laura
Furlanetto
La tecnica utilizzata.
L’autore ha, da principio, disegnato le varie
scene su fogli bianchi di formato 13x16 con penna a
inchiostro di china.
Successivamente ha passato i disegni allo scanner
convertendoli in immagine elettronica. In questo modo ha
avuto la possibilità di impaginare l’intera opera unendo il
testo alle immagini e di riprodurre il tutto a mezzo
stampante laser.
Ha ottenuto, così facendo, la prima stampa in bianco e nero
dell’intero volume. Il talento e la fantasia di Luciano
Furlanetto si sono poi espresse nella colorazione ad
acquarello dei disegni, uno ad uno.
Questo ha richiesto assoluta precisione non essendoci, in
questa fase, possibilità di errore.
La copia, unica e di grande pregio, realizzata in questo
modo per illustrare il Libro della Genesi è ora esposta in
questa sede. |
 Il
prof. Lino Bianchin presenta l'artista. Il
prof. Lino Bianchin presenta l'artista.
Quando penso a Luciano la memoria mi
rimanda ai suoi ultimi giorni. Seppure costretto a letto
dalla gravità della malattia, teneva matite, pennelli ed i
suoi amati colori ad acquerello sul ripiano appoggiato alla
coperta. Agli amici che andavano a trovarlo appariva
concentratissimo a disegnare e dipingere. Era perfettamente
cosciente dei pochi giorni che gli rimanevano e pur tuttavia
lavorava fino a quando le forze lo sorreggevano per
dipingere la Resurrezione. Non una tavola, ma tutti gli
episodi raccontati dai vangeli che hanno attinenza con il
grande tema.
Riteneva che il racconto di una singola vicenda non potesse
esaurire la complessità del messaggio in essa celato. E’ ciò
che vediamo qui in questa esposizione. Non sono illustrati
solamente alcuni dei fatti raccontati nel libro della
Genesi, ma assolutamente tutti, in una serie di 238
acquerelli. Luciano ci fa pervenire in questo modo il suo
messaggio che invita il visitatore a considerare la Parola
di Dio nella sua interezza. Niente di essa va trascurato
perché tutto va conosciuto e meditato da chi si vuol
avvicinare alla Verità.
Ha certamente avuto anche una vita normale fatta di lavoro,
affetti, impegno sociale.
(Treviso 1939). Diplomatosi presso il Liceo Artistico di
Venezia, ha frequentato l’Accademia di Venezia con il
maestro Cesetti. Ha insegnato materie artistiche per
trentasei anni nelle scuole di Treviso.
Sue opere si trovano presso collezioni private e pubbliche.
In particolare sono da segnalare:
La “Via Crucis” in terra cotta nella chiesa del Sacro Cuore
di Gesù a Treviso e, nella Chiesa Parrocchiale di S.
Floriano agli Olmi di San Biagio di Callalta, i due
affreschi di grande dimensione rappresentanti “Il Credo” e
l’ “Eucaristia e sue profezie nell’Antico Testamento”, un
grande pannello in ceramica con “il Risorto, la Vergine e
San Floriano”, la “Via Crucis” in ceramica monocroma e la
pavimentazione della corsia
 centrale
con i “33 simboli del percorso della salvezza”. centrale
con i “33 simboli del percorso della salvezza”.
Ha collaborato ad illustrare i libri “Treviso nostra” e
“Castelli e famiglie gentilizie del trevigiano in età
comunale” dello storico Prof. Giorgio Renucci. Ha curato la
pubblicazione “Chiesa Parrocchiale di S. Floriano agli Olmi
– le decorazioni 1990-1991”.
Fu, anche, stimato Designer ( allestimenti di fiere, negozi
…) ,
Ma la sua vera passione è raccontata dalle opere dipinte ad
acquerello, senza dimenticare la sua frequentazione in altre
tecniche, affresco e terra cotta.
Di lui sono da conoscere altre nobili qualità. I riferimenti
sono rivolti all’insegnante apprezzatissimo da alunni,
colleghi e genitori, al Capo Scout che mai si è sottratto da
impegni di sempre maggiore responsabilità fino ad essere
posto alla guida come capo nazionale gli Scouts d’Europa
superando le innumerevoli difficoltà rappresentate da
un’associazione che stava allora nascendo, al cittadino
impegnato nella riscoperta e nella valorizzazione della
storia di Treviso (è tra i fondatori della Società
Iconografica Trevigiana), al marito e al padre davvero
esemplare dedicatosi alle attività formative che
coinvolgevano giovani famiglie.
Rendiamo oggi onore all’artista, all’insegnante, al capo
scout, ma soprattutto all’amico fedele, disponibile e saggio
che ha saputo ben coniugare semplicità e profondità nei
rapporti che ha intrattenuto con chi ha avuto la fortuna di
incontrarlo.
La fondazione Feder Piazza, che qui rappresento, è
orgogliosa di aver collaborato, con l’allestimento di questa
mostra, seguito di altre esposizioni dedicate ai vangeli di
Luca e Matteo, a rendere il dovuto ossequio ad una persona
che molto ci ha donato e che avrà un posto significativo nel
nostro ricordo. Confidiamo che questi non rimangano episodi
isolati e cercheremo in futuro di far conoscere tutte le
altre produzioni dell’artista riguardanti il libro dei
Salmi, il Cantico dei Cantici, l’Apocalisse …
Gli acquerelli dedicati da Luciano Furlanetto al libro della
Genesi son ora raccolti in una pubblicazione edita da ADLE
Edizioni di Padova.
 GENESI GENESI
Acquerelli di Luciano Furlanetto
Presentazione di Ermenegildo Guidolin
Questa sera, dopo la
presentazione degli acquerelli ispirati al Vangelo di Matteo
avvenuta nel Battistero del Duomo di Treviso e la serata
tutta scout nella parrocchia del S. Cuore, è un’altra
occasione per ricordare Luciano Furlanetto, un uomo vivo non
soltanto nelle sue opere, ma in se stesso. Spesso, quando ci
viene a mancare una persona che amiamo e che ci ha amati,
usiamo l’espressione: - lascia un vuoto! Nel caso di
Luciano, ci ha lasciato un “pieno di immagini, di figure, di
ricordi, di esperienze, di iniziative… di vita”. Del resto,
i morti sono meno morti di quanto pensiamo; siamo noi vivi a
non accorgerci quanto non siamo del tutto vivi e quando non
lo siamo affatto.
Come per gli acquerelli dedicati al Vangelo di Matteo,
osservammo come essi facessero emergere tutta l’umanità del
messaggio di Gesù, come lo stupore della creazione artistica
ci aiutasse a cogliere ciò che ci eleva alla pienezza
dell’umano, oggi gli acquerelli scaturiti dal libro della
Genesi ci fanno incontrare il grande racconto che è
costitutivo dell’autocomprensione del popolo d’Israele, e
poi della Cristianità. Illuminanti alcune osservazioni di
Marc Chagall; in una pagina autobiografica, intitolata “Il
mio ritorno alla Bibbia”, si domanda: qual è l’artista che
non si sia ispirato alla Bibbia? “Ma io vedevo i miei
antenati per la prima volta, e mi sembrò che il mio colore
fosse il loro colore, le mie facce fossero le loro facce […]
“Né Shakespeare, né Dante, né Cervantes, nessuno è arrivato
all’altezza poetica, artistica e morale della Bibbia” […]
“Sebbene questo sia un libro che gira per il mondo in
milioni di copie, il sogno che contiene è come se fosse
sotto chiave, sommerso nelle lacrime di millenni. “Promette
una libertà diversa, un altro senso della vita…” (vedi
Luoghi dell’Infinito, n.189, novembre 2014). La Storia della
Salvezza si è espressa sul piano letterario in un grande
racconto che va dalla Genesi all’Apocalisse. E Luciano è
entrato in dialogo con la Bibbia (Genesi, Esodo, Numeri,
Cantico dei Cantici, Scritti degli Apostoli, Apocalisse)
attraverso una narrazione figurativa di personaggi, di
situazioni, di eventi mediante i quali l’artista illumina la
propria esperienza religiosa e ricerca la propria identità
di credente.
Nel gennaio del 2008, presentando la sua Genesi, con
divertita ironia scriveva: “Un libro all’anno! Quando nel
2078 compirò 139 anni, avrò completato questa lettura”.
Si potrebbe dire di Luciano: “Ha avuto
da Dio due doni: la fede e la poesia dell’arte”. Dandogli la fede,
gli ha imposto di cantarla/disegnarla tutti i giorni; e lui per anni
attuò inconsciamente con il suo lavoro artistico, un motto della
tradizione ebraica mistica, che invitava il fedele “a un canto ogni
giorno, a un canto per ogni giorno”.
Alcuni versi di David Maria Turoldo rendono bene il senso di questo
canto:
“E la quiete dell’anima
e la discesa nelle profondità,
e sentirti morire
di gioia
nella notte”.
“Genesi” è il primo libro della Bibbia,
che in cinquanta capitoli narra la creazione del mondo e dell’uomo,
il primo peccato, l’uccisione di Abele, Noè, il diluvio, la torre di
Babele, la vocazione di Abramo e la sua vita in terra di Canaan, la
distruzione di Sodoma e Gomorra, la nascita e il sacrificio di
Isacco, il ciclo di Giacobbe, Israele e di Giuseppe, l’ebreo
divenuto egiziano.
Questa elencazione di contenuti non è per ricordare nomi e vicende,
ma per trasferirci nella sequenza di immagini create dall’artista
partendo dal testo.
Avviene per noi, che le immagini suggeriscono il testo e il testo
rinvia alle immagini; avviene una doppia lettura, una doppia
comprensione che si fa interpretazione e immedesimazione.
Si compie una costante “incarnazione”, perché il racconto pittorico
costruisce una visibilità che corrisponde al nostro universo
sensibile e carnale, all’esigenza di toccare con mano.
L’immediatezza delle immagini, con la loro essenzialità realistica e
la delicatezza dei colori, trova nel disegno il proprio elemento
catalizzatore: disegno e colore trovano la loro perfetta fusione,
incontrando e perfezionando la nostra sensibilità, i nostri
sentimenti, la nostra apertura alla Storia della Salvezza. L’arte,
in Luciano, diventa esperienza di Grazia, comprensione emozionata,
attrazione interpersonale con il divino, presente nella storia
narrata e fluente negli acquerelli.
Ci soffermiamo solo sulla Creazione per l’importanza che questa idea
(concetto, rivelazione) ha avuto nella cultura e nell’arte in tutte
le sue espressioni. Filosofia, teologia, scienza, poesia, arte si
sono costantemente interrogate sulla Creazione.
Accenniamo a qualche motivo.
La Filosofia non può decidere. Che il mondo abbia avuto inizio è
assolutamente indimostrabile. Questa questione filosoficamente è
indecidibile, anche per Tommaso d’Aquino. E’ soltanto per fede che
possiamo credere che il mondo abbia avuto un inizio e la teologia
non può fare altro che giustificare la ragionevolezza di questo
assunto. La teologia può rendere plausibile, cioè dimostrare che non
è assolutamente contraddittorio, credere che il mondo abbia avuto un
inizio.
Scrive Joseph Ratzinger: “Il racconto della creazione si rivela come
‘l’illuminismo’ decisivo della storia, l’esodo dalle paure che
avevano attanagliato l’uomo. Significa la consegna del mondo alla
ragione, il riconoscimento della sua razionalità e libertà” (Cfr. “E
vide che era cosa molto buona” a cura di Andrea Bellandi, Sandro
Chierici, Eugenio Dal Pane. - Libreria Ed. Vaticana – Mostra
itinerante ideata e prodotta da Itaca Società Editrice.)
Il secondo aspetto è chiedere chi abbia dato origine al mondo. Anc he
qui la posizione può essere soltanto una posizione di fede. Che un
Dio personale, il Dio di Abramo abbia dato inizio al mondo, rimane
una posizione estranea ad ogni possibile discorso filosofico. La
filosofia non può far altro che spiegare che cosa quest’idea
comporti: l’idea di una Creazione volontaria del mondo da parte di
un Ente Supremo ha delle conseguenze determinanti per tutta la
nostra cultura e civiltà. Quali? L’idea di fare, la nostra idea di
creare. Noi riteniamo che il fare, nella sua quintessenza, sia
trarre qualcosa dal niente all’essere e che, tanto più siamo liberi,
quanto più sappiamo trarre qualcosa. Questa idea grandiosa della
Creazione dal nulla da parte di un Dio personale ha impregnato tutta
la nostra concezione del fare: dal fare tecnico-scientifico che
guarda ogni ente come suo prodotto fino alla concezione che si fonda
sulla testimonianza di fede per cui il nostro fare – in quanto siamo
simili all’Ente Supremo che ha creato il tutto – deve comunque
rivelarsi simile a quel fare. he
qui la posizione può essere soltanto una posizione di fede. Che un
Dio personale, il Dio di Abramo abbia dato inizio al mondo, rimane
una posizione estranea ad ogni possibile discorso filosofico. La
filosofia non può far altro che spiegare che cosa quest’idea
comporti: l’idea di una Creazione volontaria del mondo da parte di
un Ente Supremo ha delle conseguenze determinanti per tutta la
nostra cultura e civiltà. Quali? L’idea di fare, la nostra idea di
creare. Noi riteniamo che il fare, nella sua quintessenza, sia
trarre qualcosa dal niente all’essere e che, tanto più siamo liberi,
quanto più sappiamo trarre qualcosa. Questa idea grandiosa della
Creazione dal nulla da parte di un Dio personale ha impregnato tutta
la nostra concezione del fare: dal fare tecnico-scientifico che
guarda ogni ente come suo prodotto fino alla concezione che si fonda
sulla testimonianza di fede per cui il nostro fare – in quanto siamo
simili all’Ente Supremo che ha creato il tutto – deve comunque
rivelarsi simile a quel fare.
La scienza non parla di Creazione. La scienza non ha verità, a
differenza di quello che dicono molti; la scienza è ricerca, è
sostanzialmente umile ricerca. E’ la lotta dell’uomo per capirci
sempre di più. Nella scienza si hanno dei modelli che interpretano
quello che noi oggi sappiamo.
Una delle più belle cose che abbiamo a Padova è il battistero del
duomo con pitture di Giusto de’ Menabuoi che ha dipinto l’universo.
Quell’affresco rappresenta quel che si capiva allora dell’universo,
così come il Big Bang è la miglior teoria, il miglior modello che
sappiamo produrre oggi sulla base delle nostre osservazioni e
conoscenze. La visione del mondo del pittore del ‘300 ha la stessa
dignità scientifica e culturale del nostro Big Bang.
Per le arti e la poesia, la Creazione è una cosa così grande da non
potersi definire, anche perché tutte le opere d’arte sono Creazione
e, per l’artista ogni opera resta un mistero.
Ogni canzone, ogni secondo di musica ha
una sua genesi e la possibilità di ricerca è infinita. “La
Creazione” di Franz Joseph Haydn, ad esempio, è un brano sinfonico,
un grande oratorio, che sviluppa questo tema.
Una poetessa, Alda Merini, scrive: “Come poeta, vedo la Creazione
come una grande favola dell’amore divino. Una bella favola, enorme,
fantastica. Nell’uomo si può trovare l’impronta divina; è chiaro che
non si può vedere Dio per la strada, però si vede nella Creazione.
C’è l’impronta di Dio dappertutto. Questa è la mia idea. Quando
scrivo sono felice di scrivere e basta, non mi domando né da dove
venga né dove vada la poesia. E’ un dono e mi lascio un po’ invadere
dalla poesia. Il poeta si lascia invadere da questo amore, la poesia è anche amore, amore
dell’uomo e del creato”.
lascia invadere da questo amore, la poesia è anche amore, amore
dell’uomo e del creato”.
Luciano, fino agli ultimi giorni, la pensava così a riguardo della
sua arte. Per questo, già a Treviso, ricordavo il verso di Hölderlin:
“Poeticamente l’uomo vive il mondo”. E Luciano, con la sua presenza
e la sua attività artistica, me lo faceva ricordare sempre. Ciò che
scaturisce, guardando anche questi acquerelli della “Genesi”, è
stupore, gioia. La gioia è un altro dei nostri sensi, molto
sviluppato nei bambini, ma che viene piano piano sottratto proprio
dagli adulti che spesso la confondono con la felicità che – come
sappiamo – è fugace e transeunte. Eppure, non si dà vera opera
d’arte, se essa non ha saputo radicarsi nella gioia di cui è intrisa
l’essenza dell’artista.
Disegnare e colorare era, per Luciano, pensare, vivere, pregare.
Egli concepiva l’arte come un’inclinazione verso la luce della
conoscenza e la bellezza della creazione.
Affidiamoci, quindi, a questa gioia e cominciamo a guardare.
Leggendo la Genesi e seguendola attraverso gli acquerelli di
Luciano, incontriamo molti nomi: Adamo ed Eva, naturalmente, Caino e
Abele, Noè, Abramo, Sara, Agar, Lot, Melkisedek, Ismaele, Isacco,
Rebecca, Labano, Esaù, Giacobbe… Qui è solo un elenco, ma l’artista
– in un momento storico in cui scompare il valore identitario del
soggetto per diventare il luogo dell’artificio, maschera umana
replicata, volto di burattino esistenziale – si sofferma sulle
vicende di ciascuno, sul ruolo affidatogli dal Signore e sul destino
che lo attende. Ricupera così, con la poesia dell’arte, il volto
concreto dell’uomo e della donna, la consistenza reale della
persona.
La valenza culturale di una mostra, come di ogni altra iniziativa,
consiste nel portare l’uomo e la donna ad interrogarsi sempre più su
se stessi, sulla propria essenza, sulle proprie scelte esistenziali,
sulla propria immagine.
Nella società della comunicazione, l’uomo vive in uno stato di
allucinazione visiva – come accecato dalla luminosità dell’immagine
che la velocità gli restituisce. Incapace di leggere e interpretare
la visione, l’uomo guardandosi allo specchio non si riconosce o
addirittura non si vede più. Dopo l’arte, dopo Dio, anche l’immagine
dell’uomo è morta, nella sua assoluta originarietà e unicità.
L’identità visiva dell’uomo contemporaneo che aderisce a modelli
imposti dalla dittatura delle immagini, subisce i processi di
omologazione che, per l’appunto, uccidono la meravigliosa
soggettività dell’uomo.
Questa lettura del presente è semplicemente realistica, senza
illusioni; ma lascia spazio alla consapevolezza che ne abbiamo e
alla domanda: Ha ancora senso, in quest’epoca, la poesia dell’arte?
Risposta: Forse ha ancora più senso per riprenderci l’umano con la
sua profondità e la sua bellezza, con l’incessante ricerca della sua
verità. |