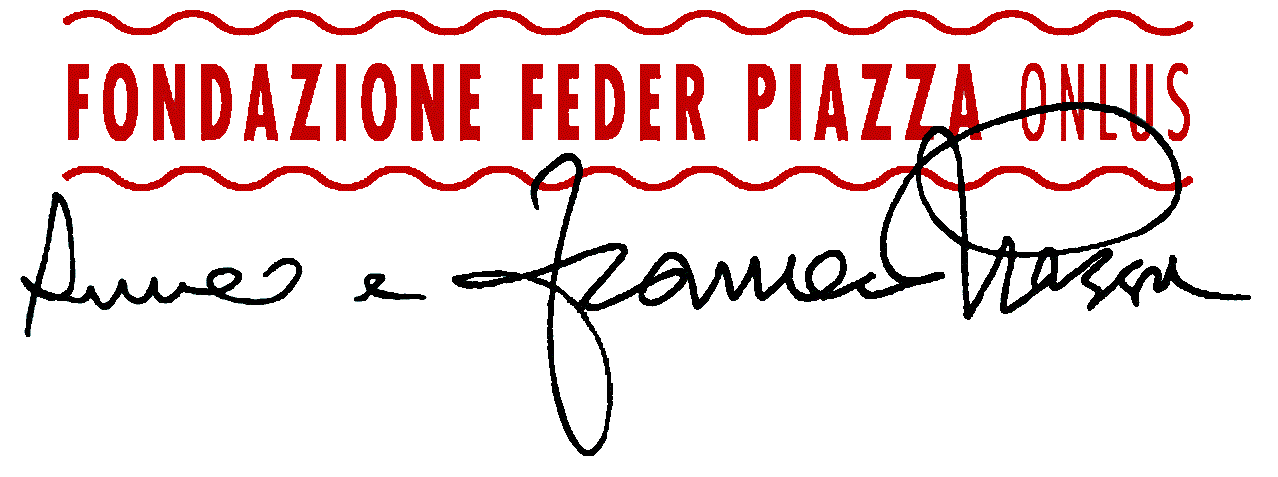|
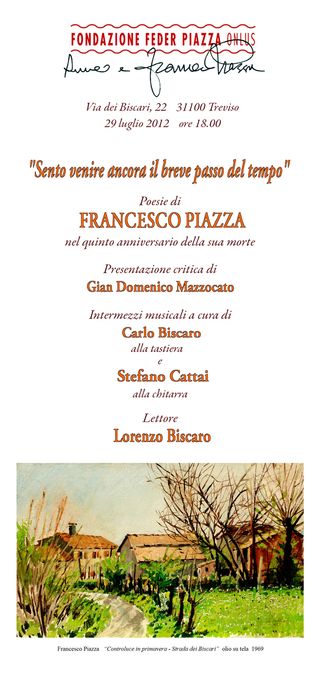
SENTO
VENIRE ANCORA
IL BREVE PASSO DEL TEMPO
di Gian Domenico Mazzocato
(per Francesco Piazza; parco della sede della Fondazione Feder
Piazza, in via dei Biscari, Treviso; 29 luglio 2012)
L’archivio Feder Piazza continua a riversare
tesori in gioiose scoperte. In particolare, sia nella condizione di
compiuta espressione sia allo stato di frammento e lacerto, versi e
poesie di Francesco Piazza.
Va da sé. Si impone con urgenza il lungo lavoro di edizione critica
dell’intera opera poetica del Nostro.
Come è noto, Piazza ha pubblicato in vita due sillogi, Alberi Anime
e Mendicavamo canti di usignoli che danno ragione e misura sia della
complessità della poetica dell’artista trevisano che della maturità
espressiva da lui raggiunta.
Danno ragione, anche, della scorrevolezza del verso, della facilità
di scrittura, della efficacia del dire magicamente sospeso tra
ricerca della parola essenziale e il lussureggiare di una
architettura gotica prima e poi barocca. Equilibrio intrinsecamente
difficile, per non dire impossibile, ma che, nella poetica di
Piazza, si realizza, apparentemente senza fatica.
Sto cercando di suggerire, per dirla in soldoni, che Piazza è un
bravo poeta, che la sua è lirica alta, che le intuizioni e le
emozioni da cui proviene sono profonde. Che Piazza ha una sua
personalissima e irripetibile sigla di scrittura, un marchio di
fabbrica, un imprinting che gli dà rilievo e spessore, una
originalità che è già di per sé un patrimonio.
Probabilmente per capire l’enigma di un equilibrio così cattivante,
tanto avviluppante non serve andare molto lontano. Basterà fermarsi
a considerare la felicità di quel sintagma, cosi denso e, ad un
tempo, così trasparente di cui ha parlato non molto tempo fa con
grande acutezza e sensibilità il critico Gigi Pianca.
Oggi mi trovo a mettere vicino il poeta emergente dall’archivio col
poeta che già mi è noto. Non rilevo discontinuità o differenze.
Trovo qualche robusta aggiunta. Di pelle, mi verrebbe fatto di dire.
La fluvialità, la marealità di Francesco Piazza.
Il poeta ti avvolge, ti sommerge. Possiede, al momento giusto, la
delicatezza di farti tirare il respiro e poi ti riafferra portandoti
di nuovo nei suoi abissi.
E mi sono chiari (ma certo non ancora indagati e vagliati a fondo)
gli stilemi della scrittura di Piazza. Che posso elencare, ripeto,
senza scavare.
La colloquialità, il senso assoluto del colore, lo straniamento
-cioè uno dei tratti fortemente caratterizzanti l’espressione
poetica- che si sostanzia nella ricerca di punti di vista inediti e
talora perfino spiazzanti.
Poi: la coesistenza del particolare minuto e dell’afflato
universale. L’uno rimanda all’altro in continuazione, non in
artificioso gioco di specchi, ma grazie ad un meccanismo più sottile
e anche più difficile da gestire e padroneggiare. Cioè la tensione
intellettuale, tutta dialettica e in vibrazione, che il poeta sa
creare.
È la tensione del filo teso su cui procede, impazzito -ma è
folgorante e folgorata follia- e morso dai miraggi, l’acrobata
ardente.
Come un acrobata ardente,
pazzo della sua gloria,
morso da immensi miraggi
che lo trattengono e spingono
io, su di una corda tesa
ho ballato
L’orizzonte profondo di chi cammina sul pericolo oscillante di una
corda.
E l’angolo minimo e perfino le frazioni di grado accanto al giro dei
360 gradi. La lente di ingrandimento ma anche il periscopio. Il
quale fa perno su se stesso e proietta l’orizzonte circolare di una
osservazione che calamita al proprio interno.
L’uso ripetuto del pronome di terza persona (hanno venduto, hanno
cancellato) che rimanda all’io recitante (la mia vita rallenta), il
vitalismo intenso che attraversa la sua visione naturalistica e che
forzatamente (anche un sistema linguistico intrinsecamente poetico
come quella italiano ha i suoi limiti) si fa nei modi espressivi del
panteismo ma che panteismo non è.
Perché c’è sempre un forte rimando ascensionale che fa da bilancia
all’immanenza.
Come in questi versi tesi che racchiudono nella trasparenza di una
teca di cristallo, dunque ugualmente vicini e lontani, la vita e la
morte (splendida e normale nella sua giacca di fustagno), le armi e
la follia, i presagi e le illusioni. Molto spesso chi si illude è
solo un povero presuntuoso.
Uccelli alberi di vita alla mattina.
Quanti di loro arriveranno a sera?
Vaga la morte in giacca di fustagno,
guerresca mascherata di bambini,
fra il granturco bruciato dall’estate,
e sotto i gelsi madidi di guazza.
Una folle viltà arma le siepi.
Ad ogni colpo, fragili le acacie
spargono un tremolio di foglie gialle.
Gli stormi decimati si disperdono
punteggia il cielo l’ansia dei superstiti
Ottobre, l’uomo gioca e si racconta,
miseramente, d’essere vincente.
Si tratta con tutta evidenza di una scena di caccia. Ma a noi
interessa la filigrana, il senso ulteriore. Non possiamo dimenticare
lo sfondo morale e mentale di questo pronunciamento. C’è un alto, il
metafisico: inconoscibile e tuttavia, per qualche strada segreta,
ri-conoscibile attraverso i suoi segni e le sue creature. Bravo chi
si avvede di orme, tracce, indizi, prodotti. E credo che qui sia già
evidente il trapasso. Perché ancora una volta io sono
irresistibilmente (e infatti non resisto) tentato dal salto alla
dimensione etica della scrittura di Francesco Piazza.
Che mai come in questi momenti di riflessione avverto come il mio
fraterno, sempre presente, mai andato, amico e maestro Checco.
Non è solo il fatto che in questo nuovo mannello (via via fattosi
corposo covone) di versi io colga quanto già sapevo e cioè la
assoluta contiguità tra parola scritta e segno inciso. Piazza poeta
è una cosa sola con Piazza pittore e incisore. Nessuna incisione di
Piazza può dirsi compiuta senza la didascalia puntigliosamente
cercata e, ad un tempo, ispiratrice e matrice dell’incisione stessa.
Il rapporto tra acquaforte e didascalia (chi ha generato chi) non è
mai chiaro fino in fondo e anzi gioca su tale ambiguità, se ne nutre
e se ne corrobora.
Ma, ripeto, non solo. C’è anche questa struttura piramidale e
ascensionale che ripudia la brutta e cattiva idea (ahimè, frutto
anche di un catechismo cristiano un po’ da accatto) dell’uomo come
re dell’universo.
Qui c’è molto di più. Un convincimento radicale che il poeta
partecipa al lettore.
L’uomo respira perché respira l’universo. Non lo domina, ne dipende,
vi partecipa. Vi contribuisce se ha buona volontà di suo e se ha
ricevuto buona educazione da buoni maestri. Il microcosmo come il
macrocosmo. Se i polmoni dell’universo cessano di contrarsi, l’uomo
muore. Non re, ma servo consapevole, punta estrema pensante e
responsabile.
Si muovono risposte importanti in queste poesie di Piazza.
Lasciatemi fare qualche riflessione alla buona, dunque sommaria e
approssimativa.
Perché serve contestualizzare. Dopo Pascoli (che ha insegnato tanto
a molti) e D’Annunzio (che ha insegnato poco a quasi nessuno) il
Novecento ha cercato di interrogarsi sulla poesia chiedendosi che
cosa sia la poesia stessa.
Tutti i precedenti archetipi poetici erano migrati in polverose
soffitte. Dalle quali, come un virus, era scesa nell’animo degli
umani una febbre definitoria. Ma cos’è la poesia?
Febbre obbligata a rimanere nel vago e a non guarire mai del tutto.
Ci siamo risposti (e bene, non si può recriminare su nulla, con
molto equilibrio) che in un secolo di grande incertezze, di valori
stravolti, di verità appena intuite, di verità che appaiono tali
oggi e non lo sono più domani, la poesia era la trascrizione del
balbettio dell’uomo che cerca di capire e intuire.
Di spiegare a se stesso e magari un po’ anche agli altri. La verità
si intuisce per frammenti, per illuminazioni brevi e improvvise. Un
buon poeta è colui che sa cogliere collegamenti e relazioni. Dico
buon poeta, ma anche buon filosofo, buon artista e quant’altro.
E poi cerca di comporre un puzzle credibile per decifrare il grande
mistero che circonda l’uomo.
Intendiamoci, una buona risposta. Appagante e convincente.
Poi, sul declinare del secolo, ci siamo accorti che era una risposta
a maglie troppo larghe.
Filtrava tutto: l’Ermetismo (Ungaretti al pari di Montale che dal
poeta d’Alessandria d’Egitto è lontanissimo, Quasimodo che ermetico
non è, anche se per uno dei tanti equivoci che caratterizzano la
storia del Nobel ha preso proprio il premio destinato
all’Ermetismo), le mille correnti dei postermetici, il
neostilnovismo di Umberto Saba, perfino la poesia civile di
Pasolini, e la poesia/diario di Cesare Pavese.
Tutto insomma. Cioè troppo. Un magma ricco e vitale nel fluire del
quale però si corrono rischi di miopia e presbiopia perché possono
sfuggire collegamenti, differenze, analogie.
Spetta ad una generazione di grandi poeti (Luzi, Sereni, Nelo Risi,
Zanzotto) l’averci messi sull’avviso esplorando territori diversi e
distanti tra loro. Dai mistieroi dialettali di Andrea Zanzotto agli
spiritualisti francesi che tanto hanno suggestionato Mario Luzi.
Ci hanno fatto capire che forse la domanda vera è un’altra. Vera:
sarebbe meglio dire più matura, frutto di un travaglio mai cessato.
La formulo, questa domanda. Se la pone il poeta e la riversa sul suo
lettore: a che serve la poesia? che senso ha fare poesia, se essa è
lettura di un universo negativo in cui tutto è male?
Non dimentichiamolo mai il fardello insopportabilmente pesante e
concentrato di un Novecento (il secolo breve, come è stato definito)
in cui anche Dio ha dormito e ha abbandonato, come si è lasciato
dire Benedetto XVI tra i reticolati e i mattatoi di Auschwitz.
Sembrerebbe l’epitaffio per ogni possibile poesia. E non è così,
invece.
Faccio mie le parole che mi disse Nelo Risi in una intervista di
ormai parecchi anni fa. Nelo Risi, classe 1920, è testimone del
secolo, una roccia che sfida i decenni. Lui mi aveva appena
disegnato il suo mondo assolutamente negativo e chiuso ad ogni
speranza. “Accidenti, Nelo, e tu continui a fare il poeta, gli
dissi, che senso ha?” E la replica è stata che alla fin dei conti la
poesia, parole sue, “resta pur sempre l’unico modo per raccontare la
vita rispettandone il ritmo”.
Potete immaginare cosa è capitato in me quando, non molto tempo
dopo, ho incontrato la poesia di Piazza. Come ho avvertito vere e
profetiche e sacre e divine -soprattutto incarnate- le parole di
Nelo Risi.
Il ritmo della vita.
Più tardi sentirete, in appassionata lettura, alcuni di questi versi
riemersi alla luce e pazientemente trascritti (grazie Gianni, grazie
Giorgio, grazie alla fertile e instancabile curiosità di Fiorella).
Nessuna pretesa da parte mia se non aiutare l’ascolto. Una messa
fuoco, qualche sottolineatura, qualche passaggio da tenere d’occhio.
Intanto. Come fisicamente atteggiarsi per l’ascolto o, se volete,
per la lettura?
Il lettore deve stare, per così dire, sopra e dentro la visione di
Francesco Piazza.
Come la gazza di questi versi del giugno 1988.
Solo la gazza,
invadente e proterva,
provocatrice fuggiasca,
bella e reietta
così sontuosa e regale
come aquilone orientale.
Accettiamo la provocazione. Avvertiamo come -bella e reietta- la
bellezza non sia il lasciapassare universale ma qualcosa di
difficile da gestire.
Però che in qualche modo la si debba gestire, è sicuro.
E voliamo: ma ricordo che l’aquilone ha un filo che lo lega e lo
ancora a terra, che serve a timonarlo e a dirigerlo.
Confesso che questa gazza che fa spuntare dalle vecchie carte, con
dolce arroganza, il becco ladrone, mi ha passata l’anima col suo
volo superbo ed è rimasta là. Si aggira, svolazza, non vuole sapere
di andarsene. Mi fa perfino un po’ di coccole.
Sarà anche per l’aggettivazione tutta giocata sul sottile
contrappunto dei contrari. Una sorta di scala, ma attenti ai pioli
che ci sono e non ci sono, una scala che invita ad issarsi alti come
l’aquilone. Invadente, proterva, provocatrice, fuggiasca, bella,
reietta, sontuosa, regale. E allora la tentazione è di volare come
l’aquilone. Bassi, radenti e orientali.
Orientali: c’è il senso del sole nascente, perché credo che Piazza
volesse dire che il suo cervo volante viene dall’aurora, dalla plaga
dove la luce nasce e da cui inizia a diffondersi. E passiamo in
rassegna gli oggetti che lì in basso (ma ripeto, non troppo in
basso, appena qualche spanna di filo) si disegnano o si intuiscono.
Quella stufa che innalza al cielo i fumi sacrificali del legno che
arde.
Scoppietta l’acacia,
ronfa il castagno,
il faggio con lieve respiro, brucia.
Tutto canta il suo creatore
anche nell’olocausto della stufa.
Ogni voce è diversa
per me, uomo, che attendo…
fuori la giornata tersa
è di un gelo tremendo.
L’uomo in attesa. E quei simulacri così inquietanti. Piazza annota
nel gennaio del ’94
Ergono le loro steli
i pioppi screpolati
e assistono senza tremare
allo svolgersi dei giorni.
Preceduto -il pioppo/stele- da un frammento (in correzione di altri
versi che evidentemente non suonavano opportuni al poeta)
dell’agosto ’91
un obelisco di marmo e d’oro
in un deserto di mobile sabbia
Le steli, l’obelisco stabile contrapposto alla mobilità sfuggente
della sabbia.
Come non sentirvi la forza della profezia? Penso all’ultima lastra,
Alberi in giardino, interrotta dall’irrompere del fulmine maligno e
in cui, citando il salmo 36, Piazza chiama tutti e ognuno al
raccoglimento: Stai in silenzio davanti al Signore.
Lui che ci offre di continuo lezioni di parola. Piazza è il nuovo
Adamo che mette (potenza della parola) un nome ad ogni oggetto, come
ci suggerisce Pascoli nella prosa dedicata al Fanciullino o il dio,
pietoso della insipienza degli umani, di cui parla Leopardi nella
prima delle Operette Morali, La storia del genere umano. Versi del
novembre ’94.
Cadono le foglie del tiglio
sfibrate, scolorite, stanche …
è tutto un frusciare, un bisbiglio
un continuo sipario che cala
in flottanti lampeggi gialli,
dai platani, le betulle, i faggi
gli aceri, in sulfurei raggi
obliqui di preziosi metalli.
Sulla terra, Danae riversa,
scende il re degli dei
in una pioggia d’oro.
E lì, in basso, dove la mano tiene ancorato l’aquilone orientale,
magari sperando che non arrivi un refolo di vento maligno e
improvviso, i ritmi sono diversi. Alludono alla lentezza, alla
quotidianità.
La mia vita è più lenta,
tutto mi si rallenta,
e la mia mano è vecchia
quando l’occhio mi cade
sul pennello che tiene,
quando la guardo che si posa
sul cavalletto
prima di portar dentro il quadretto
dipinto con gioiosa,
giovanile ed ansiosa
anima che si appaga.
È il Piazza, ugualmente pensoso e scherzoso, che ha messo alla prova
(settembre ’91) l’estate appena trascorsa. Il Piazza che incede
-incipit imperiale!- in una pioggia dorata.
Sono qui che cammino
in una pioggia dorata
di foglie, in giardino.
L’estate è passata
con riservata eleganza.
Quanto l’abbiamo attesa
e quanto ci aveva promesso!
Valutiamola, adesso.
È il Piazza capace di confondere e rimescolare, senza annullarli o
seppellirli in un colpevole oblio, i confini tra morte e vita nel
ricordo della mamma.
Sei qui, non vai più via.
Sei come a casa tua, a casa mia.
Non sei nel cimitero di campagna,
silenzi vuoti, estranea pace, poche
memorie di sfuggita, la presenza
di brevi soste, mamma, io bambino.
Tu sei con me, le tue parole, i passi,
le canzoni accennate a mezza voce,
i detti ripetuti, i tuoi sorrisi,
le tue sfuriate, le cocciute offese,
gli attimi di dolcezza,
debolezza,
il ritornare ancora alla fierezza:
la tua forza di donna solitaria.
Tono tenue, pensiero robusto e dolente.
Il panorama del dubbio, del rimpianto, del dolore che si impasta nel
desiderio. Del dopo, di quello che sarà di noi dopo il grande salto
nel buio.
Nostalgia, in senso alto e soprattutto in senso etimologico:
l’apprensione, la paura, il batticuore per il nostos, cioè per il
ritorno. Nel dubbio il poeta sceglie il coraggio dell’assenza. Non
si saprebbe nemmeno come dire: la contraddizione, l’ossimoro di una
passività attiva. Il poeta è conciliatore della coscienza, custode
meravigliato, testimone ammutolito.

E io perdente, discosto,
incerto, sfiduciato, passivo
io che nel dubbio ho scelto l’assenza,
il non pensare, il non cercare,
il fuggitivo,
il conciliatore della coscienza
ecco, io vivo
e sono custode meravigliato
della tua erompente vitalità.
Testimone ammutolito
e appesantito
dal grande fardello
della testimonianza
che mi schiaccia e mi grava.
Aspetto solo di ritrovarti
Anche per noi, al posto nostro e in nome nostro, la sensibilità di
Piazza avverte il sopraggiungere del breve passo del tempo. In
realtà l’aquilone che viene da Oriente e dal sole che nasce, non
smette di volare, non abbandona mai quelle quattro spanne di filo
che lo ancorano al terreno.
Quel filo assomiglia alla speranza e la speranza presuppone sempre
un perdono, una remissione del male che è in noi. Remissione
provvisoria ahimè, e mai definitiva.
La illumina, a tratti, una luce minacciata -un sole di eclissi- in
cui si rivelano le cose percorse -le foglie irose- da fremiti
misteriosi e però vitali.
Sarà un sole di eclissi, tagliato
da foglie che irose si inseguono.
Oh allodola, o vela tremante
o canzone d’estate, pentita
in un bosco che ha tappeto di neve.
Perché il testimone ammutolito è anche sentinella e vedetta.
Infatti è protetto dallo scudo e dalla corazza del silenzio
interiore che ha saputo conquistarsi.
La sua missione è semplice e grandiosa. Trattenerla, quella luce di
eclissi.

Io lo trattengo il sole,
fin quando dietro ai rigidi castagni
brucia di freddo fuoco
il cielo, molle,
soffice di fiati sospesi come veli.
Io lo trattengo il sole
e dalle lastre
d’ondulati bagliori, alla finestra
vigilo il digradare della luce
Perché ogni giorno viene sera e, come scrive Checco nell’agosto del
1998,
…di valido resta
soltanto, per tutte le sere,
il mio quotidiano “miserere”.
DOPO L'INCONTRO
Caro Lino,
durante le ore passate domenica pomeriggio nel giardino di Anna e
Francesco
mi sono venuti alla mente alcuni versi che ho scritto
frettolosamente a matita lì sul posto.
Ieri li ho rivisti e ho composto questa poesia che ti allego,
pensando che vi faccia piacere.
Un abbraccio, Mariella
Il bosco-giardino di Anna e Francesco
Fiato, respiro, vento
si sente improvviso
e ci soccorre lo spazio
tra bocca e bocca.
I tuoi alti pioppi
ti salutano:
un sussulto al tuo nome,
Francesco,
come quello del bimbo
in seno.
Un picchio strilla
schizzando dal verde folto
nel cencio pallido
di questo cielo
affogato e faticoso di luglio
in cui tu, nuovamente,
ci dici addio.
Summertime…
e noi qui, con
la nostra giovane
vita che rincorre
con le note,
sull’erba dello stesso prato,
tanto di ciò che è stato.
La tua morte così ingiusta,
Anna, che ci scortica ancora
con la forza di parole
in rima ripetute
da questo tuo perfetto amante
nel suo inestimabile amore
per te
che mai si piega.
Mariella, 29 luglio 2012
|